UNA GRANDIOSA SCONFITTA
“Un giorno felice è un giorno felice.
Ce ne sono così pochi, in una vita.
Godetevelo.”
Richard Ford
Essere malato significa dipendere dagli altri. Nessuno apprezza la libertà quando è sano. I sani passano il loro tempo altrove, reclusi nelle loro angosce in attesa di chissà cosa. Perché essere sani non vuol dire essere felici. La vera malattia, quella con un appropriato nome scientifico, costringe a calarsi nella realtà. Solo allora si comprende lo spreco e come sia stato facile rovinarsi la vita per dare un senso all’infelicità.
Da cinque anni sono inchiodata in un letto d’ospedale come cristo in croce, una malattia degenerativa, hanno sentenziato i medici. Gesti semplici come bere un bicchiere d’acqua, defecare in santa pace seduta sulla tazza del cesso leggendo un libro o scaccolarmi il naso in maniera libidinosa sono ora impossibili. Ho sempre bisogno di assistenza. Una persona governa le mie azioni quotidiane, mi pulisce il culo, mi nutre, mi veste.
La mia intimità non esiste più. Ho pianto, ho imprecato ma la mia condizione non è cambiata. Sarà così per sempre. Prima potevo anche parlare, ora nemmeno un suono esce dalla mia bocca. Arrendersi ai fatti è l’unica cosa sensata che bisognava fare. Ed è quello che ho fatto.
Non che tutti i malati la pensino come me. Alcuni, per esempio, nella malattia rinascono e affermano di aver ritrovato sé stessi e di aver finalmente compreso il valore della vita, gente che dice di sentire il peso della propria anima, 21 grammi di illusioni e incoscienza, dico io.
Poi ci sono gli illuminati, quelli che lottano ogni giorno nonostante la loro abnorme condizione di infermità. Sportivi, scienziati, artisti, gente che semina speranze. Dal fantastico televisore da quarantadue pollici portato qui dalle mie amorevoli figlie ho guardato un documentario sulle sorprendenti imprese di queste persone, uomini e donne speciali, ha detto la giornalista, proprio così s-p-e-c-i-a-l-i. L’operatore ha poi fatto un primo piano sul volto angelico della giornalista mentre i suoi occhi sprofondavano in una banale e ridicola commozione. Io in quel documentario non riuscivo a sopportare la presunzione, la vittoria sulla malattia come se al mondo fossimo tutti uguali. Ma di uguale per me non c’era nulla da mostrare. Io non faccio parte di quelle persone speciali, io sono semplicemente un ammasso di carne e ossa che attende la fine.
Il cervello è l’unica cosa che la malattia non ha voluto, posso pensare, ricordare o dimenticare, dipende dai giorni.
Le mie amorevoli figlie, di tanto in tanto vengono a trovarmi e portano con loro sempre delle vecchie fotografie: i compleanni, le sante feste, le gite della domenica, i nipoti, i matrimoni, io da giovane, i miei genitori. La famiglia è importante, dicono, la famiglia è il ricordo più bello. Mamma ti abbiamo voluto bene e te ne vogliamo ancora, non sei sola, mi dicono. Puttanate! Non capiscono il male che mi fanno mostrandomi ciò che non esiste più. Quelle immagini sono la ripugnante dimostrazione che il tempo mi sta divorando, immagini che andrebbero distrutte se solo qualcuna delle mie figlie avesse un po’ di buon senso. Per fortuna quello che penso veramente non possono più sentirlo, ne morirebbero, poverine.
Quando vengono a trovarmi, le mie figlie riempiono questa stanza con le loro voci stridule e assordanti, interrompono i miei pensieri e vorrei tanto urlare: Andatevene, non ne posso più! La vostra presenza mi soffoca! Ma loro ne morirebbero e in fondo non sono una madre così cattiva.
Cattiva lo sono stata, quando potevo camminare e andare al cesso da sola. Da sola facevo un sacco di cose, cose che le mie figlie nemmeno sanno e, viste le circostanze, non sapranno mai. Le possedevo, le mie figlie, dirigevo le loro esistenze secondo le mie regole e le mie esigenze. Loro, deboli di carattere e insicure, si lasciavano guidare senza fiatare, proprio come il padre, un inetto, un viscido invertebrato.
Mio marito è morto prima di me. Quando ha capito che non c’era più speranza per la mia guarigione ha bevuto un’intera bottiglia di candeggina. La sua è stata una morte orribile. Straziante. La puzza di candeggina ci è rimasta in casa per settimane.
Ai suoi funerali io non c’ero. Le mie amorevoli figlie, per rendermi partecipe del grande evento, chiamarono un fotografo. Non s’era mai visto un fotografo a un funerale. Così ho avuto un album del funerale di mio marito. Ogni momento è stato fissato dall’occhio sensibile del fotografo: pianti, abbracci, svenimenti, disperazione, tutto. Il fotografo all’inizio era imbarazzato, nessuno mai gli aveva chiesto un servizio del genere, immortalare il dolore e non la gioia sembrava una cosa disumana. Ma mentre scattava, lui si liberò dalla timidezza e riuscì a catturare ogni emozione. Fissò nell’obiettivo più di quanto avesse sperato, volò sopra sopra al dolore come un avvoltoio e fu per lui come una liberazione e una scoperta.
Mio marito ora riposa in pace, lui non ha visto l’album del suo funerale, io sì. Poi le mie figlie hanno raccolto in un cassetto le poche cose importanti del padre, il resto lo hanno buttato. Il ricordo è nel cuore, hanno detto. E poiché sono prigioniera di questo letto, hanno pensato bene di buttare anche le mie di cose: abiti, scarpe, cappotti. Mentre lo facevano hanno pianto ma liberare i cassetti era necessario, bisognava fare spazio.
Sono malata e non posso nemmeno suicidarmi, avrei dovuto pensarci prima, ma prima di adesso volevo ancora vivere, credevo ancora mi aggiustassero come una cosa rotta. Ma le cose rotte come me non si aggiustano e allora sono condannata a restare qui come un vegetale per i giorni che restano, come una pianta senza più radici.
Non parlo più con nessuna delle mie amorevoli figlie. Le guardo e mi fanno pena. ANDATEVENE VIA! urlo nella mia testa.
I giorni muoiono lentamente e ho parecchio tempo per pensare al passato, al presente e al futuro, ho la libertà di fare un riposino quando voglio, faccio pipì e sforno enormi batuffoli di merda a qualsiasi ora del giorno.
Forse questa condizione non è da disprezzare, la mia solitudine è abitare in santa pace la mia malattia senza dover negoziare con gli altri alcunché. Perché anche la malattia va addomesticata.
Sono malata e più vera di molti altri malati che fingono di essere malati per scovare da qualche parte il proprio io da devastare. Io non ho più nulla da devastare, ci ha già pensato la malattia. La mia è una condizione privilegiata, posso assistere in prima fila alla mia grandiosa sconfitta mentre osservo incredula chi continua ad affannarsi senza aver compreso che le cose, certe volte, vanno proprio come devono andare.
©MimmaRapicano
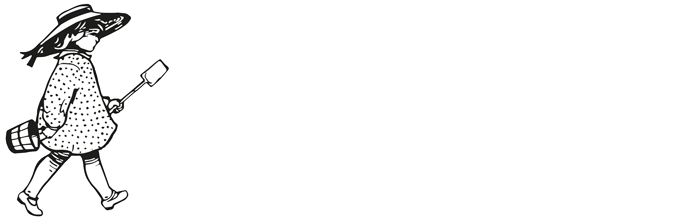
Sei brava come sempre, è uno dei racconti che più mi ha coperto di tristezza, riesco a dare immagine alle parole, allla persona e all’attesa.