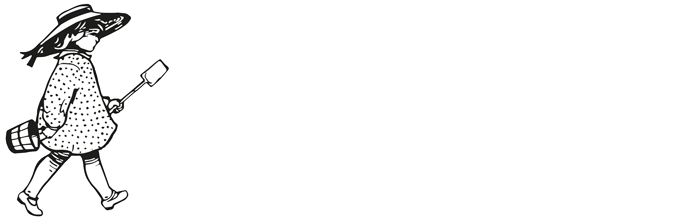IL TARTARUGA
In certe ore del giorno la stazione di Milano sembra un formicaio con il via vai di facchini, macchinisti, capitreno, viaggiatori e tutta quella gente che nessuno sa perché sta lì, pur non dovendo né partire né aspettare un ritorno.
Un uomo dal passo svelto è così distratto che urta e quasi fa cadere una ragazza con lo zaino in spalla che guarda il tabellone delle partenze. La signora in pelliccia che le è accanto tiene al braccio sinistro un lussuoso trasportino Gucci con dentro un cagnolino bianco e tra l’indice e il medio della mano destra una sigaretta. Fuma con pacata indifferenza. Strani figuri si aggirano tra la folla in cerca della vittima da ripulire. E tutta questa moltitudine, che guarda pur senza vedere, mette paura a una bambina che s’aggrappa con le braccine alla gamba della mamma.
È l’ora di punta e i bar sono pieni di avventori in cerca di ristoro, che qui significa un tramezzino secco e stopposo.
Sulla banchina del primo binario, tra i bagni pubblici e gli spogliatoi del personale viaggiante, si trova l’ufficio degli oggetti smarriti in cui lavora il Tartaruga. Nessuno, tra chi lavora o frequenta abitualmente la stazione di Milano, ne conosce il vero nome. Forse quel soprannome gli è stato dato per il suo incedere lento, quel trascinare l’esile figura con il capo chino teso in avanti. O forse perché, in qualsiasi stagione, come un guscio, indossa sempre un consumato impermeabile beige a doppio petto. Sulla sua faccia, bruna e avvizzita tanto da sembrare un vecchio di cent’anni, spicca un naso schiacciato con enormi narici che guardano il cielo.
Il Tartaruga non ama far chiacchiere con gli altri, è taciturno e solitario. Molti hanno cercato di interrogarlo, estorcergli qualche notizia sul suo passato, ma lui alza le spalle strette e con una voce appena udibile dà sempre la stessa risposta: “Non c’è niente di interessante nella vita di un custode”.
Gran parte del giorno se ne sta nel suo ufficio, uno stanzone poco illuminato, rannicchiato su una sedia girevole dietro una scrivania tarlata. Un tempo in quell’ufficio c’era un andirivieni di gente di ogni tipo, le cose perdute in stazione o sui treni venivano cercate, ma negli ultimi anni, invece, nessuno reclama più gli oggetti smarriti e quei pochi che ancora gli consegnano lui li cataloga meticolosamente. Su un grande quaderno segna la data e l’ora del ritrovamento, la forma, la dimensione e il colore dell’oggetto che prende in custodia. Si comporta come se il misterioso proprietario potesse far capolino sull’uscio da un momento all’altro per chiederne la restituzione. Alcune volte l’hanno sorpreso con l’orecchio appoggiato a un oggetto, congelato in quella posizione in attesa di chissà cosa. Altre con lo sguardo fisso su una pagina e con la penna in una mano sospesa tra la scrivania e la sua faccia.
In quell’ufficio sono custoditi gli oggetti più disparati: valige piccole e grandi, cappelli, mazzi di chiavi, ombrelli, un ukulele, un numero imprecisato di beauty case, dentiere, una frusta da domatore, manette, telefonini e tablet, un mocassino da uomo, uno soltanto. Ma il fatto più strano è successo quando un addetto delle pulizie ha trovato sul treno Zurigo-Milano un mazzetto di fotografie tenute insieme da un elastico. L’immagine era sempre la stessa: il ritratto di un uomo con le spalle nude e una lampada sulla fronte simile a quelle che usano gli escursionisti. Il viso dell’uomo, sudato e pieno di rughe, ha un naso spaventevole e informe, al posto degli occhi due fessure da cui si intravede appena il nero delle pupille. Il Tartaruga fissò a lungo l’immagine, poi chiuse le fotografie in una bustina di plastica trasparente e, come ogni volta, annotò la data, il luogo e l’ora del ritrovamento sul suo quaderno. Una settimana dopo, sempre sul treno Zurigo-Milano, lo stesso addetto alle pulizie aveva trovato altre fotografie, uguali alle precedenti e gliele aveva consegnate. Anche queste furono archiviate.
Ogni sera, prima di rintanarsi nel suo stambugio, una stanza ammobiliata al piano terra di un modesto caseggiato poco distante dalla stazione, il Tartaruga trascorre qualche ora nell’osteria di Rosetta, all’angolo di via Soperga. Nell’antica osteria si respira l’aria di una Milano d’altri tempi, quella operaia e nebbiosa. Con gli anni la città è cambiata parecchio, meglio o peggio dipende dai punti di vista e dall’età di chi ne dà il giudizio. Ma l’osteria di Rosetta, con il bancone di legno, sedie e tavoli sgangherati, i bicchieri opachi e graffiati, il pavimento a rombi bianchi e neri, resiste alla modernità nonostante sia circondata dalle ampie e scintillanti vetrine di un ristorante giapponese da un lato e da un bistrot alla francese dall’altro.
L’osteria è frequentata da chi lavora in stazione e da quella gente a cui piace ancora un pasto genuino e a buon prezzo. È una bella combriccola quella che si riunisce da Rosetta e spesso, dopo qualche bicchiere di troppo, la lingua si scioglie e tutti si mettono a raccontare dei fatti più strani accaduti in stazione. Il Tartaruga li ascolta seduto al solito tavolo vicino all’ingresso sorseggiando con gusto del vino rosso. Ogni tanto accenna un sorriso o alza un sopracciglio, è quello il suo modo di partecipare alle chiacchiere degli avventori. Lui, invece, di cose ne conosce e potrebbe ammutolirli tuttise raccontasse quello che sente avvicinando l’orecchio agli oggetti che custodisce. Ascolta l’amarezza e la disperazione di chi li ha posseduti, altre volte sente l’allegria, le risate, i pianti, voci di adulti e di bambini. Con gli anni ha imparato che ogni oggetto ha una sua storia; alcune meriterebbero d’essere raccontate, se soltanto ad ascoltarle ci fosse un abile scrittore. Ma lui, non avendo doti di narratore, si limita a scrivere sul suo quaderno dei ritrovamenti delle noticine per ricordarsi della voce di ogni oggetto, poco più che postille in un indecifrabile linguaggio che nessuno, ne è certo, leggerà mai.
Prima di abbandonare l’aria fumosa dell’osteria, alza il bicchiere con l’ultimo dito di vino, accenna un saluto, tracanna e poi sparisce.
Il Tartaruga di cose strane in vita sua ne ha viste e sentite, eppure la faccia dell’escursionista nelle foto ritrovate sul treno lo tormenta. Quei lineamenti hanno qualcosa di familiare e inquietante. Eppure, per la prima volta, avvicinando l’orecchio alle fotografie smarrite, non sente nessuna voce, neanche un bisbiglio, nulla. E non riesce a comprendere perché desti in lui tanto interesse l’identità di uno sconosciuto.
Le fotografie sono state abbandonate di proposito? L’uomo è svizzero o italiano? S’è forse perso a Milano e qualcuno lo cerca? Domande su domande che ripete ossessivamente nella sua testa.
Deciso a risolvere il mistero, il Tartaruga prende la bustina di plastica con le fotografie, ne estrae una e la poggia sulla scrivania. Con una lente di ingrandimento studia i particolari: lo sfondo è poco illuminato e gli risulta difficile distinguere cosa ci sia dietro o accanto all’uomo con la torcia sulla fronte. Poi all’improvviso mette nella tasca dell’impermeabile la fotografia ed esce dall’ufficio in cerca dell’addetto alle pulizie sul treno Zurigo-Milano.
Trovato l’uomo, lo sottopone a un vero e proprio interrogatorio: “Dove hai trovato le fotografie, in prima o seconda classe?”. “Erano nascoste o lasciate in bella vista?”
Lo interroga come se fosse un detective nel pieno di indagini complicate e segretissime. Mentre lo ascolta, l’operaio, si passa più volte una mano sulla fronte visibilmente spazientito. E quando il Tartaruga smette di incalzarlo con le sue sciocche domande e lo fissa in attesa di importanti rivelazioni, quello gli stringe le spalle con entrambe le mani, lo scuote più volte e poi lo manda a quel paese. Per nulla impressionato dallo scossone ricevuto, il Tartaruga ritorna nel suo ufficio. Cammina avanti e indietro nello stanzone con le braccia dietro la schiena, allunga e ritrae il collo, come se quel movimento innaturale lo aiutasse a pensare. Attende una folgorante intuizione per proseguire le indagini. «Zurigo! – esclama. – Devo andare a Zurigo!».
Quando arriva da Rosetta ordina il solito mezzo litro di vino rosso e si siede al solito tavolo accanto all’ingresso. Prende dalla tasca la fotografia dell’escursionista e la sistema sul tavolo. Dopo ogni sorso china il capo e fissa l’immagine senza badare a ciò che accade nell’osteria che intanto s’è affollata. Con quell’insolito comportamento il Tartaruga attira l’attenzione di tutti gli avventori che parlano a bassa voce per timore di disturbarlo, fanno cenni col capo, alcuni sussurrano le ipotesi più strampalate. Rosetta, donna schietta e risoluta, stanca del bisbiglio generale e dell’immobilità che non porta vino alle bocche asciutte, esce dal bancone e raggiunge il tavolo vicino all’ingresso per curiosare e vedere con i suoi occhi cosa ci sia di tanto interessante su quel pezzo di carta. Il Tartaruga non s’accorge della giunonica presenza al suo fianco. Di colpo Rosetta scoppia in una fragorosa risata che lo fa sobbalzare. Ora vede l’ostessa con la faccia paffuta e il corpo rotondo che sussulta: «Il Tartaruga s’è fatto il ritratto mezzo nudo… – dice ad alta voce la donna. – E pure una lampadina in fronte, s’è messo». In un baleno, come risvegliati dal torpore, tutti i presenti circondano il tavolo. Non sono tanti, ma accalcati uno sull’altro, faccia a faccia con il Tartaruga, gli rubano l’aria.
Decine di occhi fissano la fotografia dell’escursionista e alla risata di Rosetta si aggiunge un’ilarità generale. Dove l’hai fatta? Con chi eri? Volevi darla alla morosa?, gli domandano e poi ridono di lui. Dalla calca, un tipo smilzo con lunghe braccia afferra la fotografia dal tavolo e si allontana in un angolo della sala. Il Tartaruga è pallido, le narici del suo naso si allargano, si alza di scatto, la sedia cade all’indietro tonfando sul pavimento, dalla bocca sottile esce un sibilo come un rantolo d’animale mai udito prima. Lo spavento ammutolisce tutti quanti. Si fa largo tra la folla e raggiunge il tipo smilzo per strappargli dalle mani la sua fotografia.
Il Tartaruga esce dall’osteria barcollando. È confuso, si ferma per qualche istante sul marciapiede poi svolta a sinistra. Vuole allontanarsi il più possibile da quel posto, da quelle risate che gli rimbombano ancora nelle orecchie.
In strada c’è una nebbia gialla e densa, i contorni dei palazzi sono pennellate incerte. Milano è insolitamente silenziosa, non un passante, un’automobile, un tram o una bicicletta, sembra sparita l’intera umanità. Si guarda intorno, non sa dove sta andando e nell’aria un tanfo di palude soffocante. Il rintocco dei suoi passi incerti è l’unica cosa che può sentire. Sfinito, come se fossero passati cent’anni dall’ultimo sorso di vino, si appoggia a un lampione per non cadere. In mano ha ancora la fotografia dell’escursionista, l’avvicina fin quasi ad annusarla con le sue grandi narici, poi l’allontana. Cerca la giusta distanza per capire, per vedere quello che gli altri hanno visto. Scuote la testa e si rammarica di non averlo capito prima: se nessuna voce gli arrivava da quelle fotografie era perché non c’era nessuna storia da ascoltare, nessuno da cercare. Lo sconosciuto della fotografia, quello che tanto gli somigliava, sparisce lentamente fino a diventare un’ombra, un sottile velo di niente. Le gambe gli tremano, la faccia, inumidita dalle lacrime, non ha più colore. Accartoccia la fotografia e la getta via. Mentre si allontana alza il bavero dell’impermeabile e infila le mani nelle tasche. In una ha ancora il biglietto Milano-Zurigo comprato qualche ora prima. Lo estrae dalla tasca e senza guardarlo lo lascia cadere. Il biglietto ondeggia, la nebbia sembra trattenerlo o ritardarne la caduta.
[Racconto pubblicato sulla rivista Quaerere, febbraio 2021]