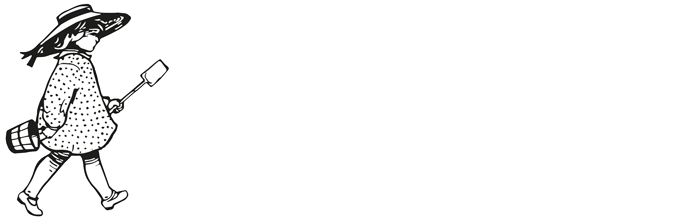BAR VOYAGE
Philip trascorreva ore a scarabocchiare il foglio che aveva davanti, tanto per fare qualcosa di utile, per riempire il tempo tra uno sbadiglio e una sigaretta. I fogli si accatastavano ai piedi della sua scrivania e transennavano ogni speranza di ritornare… ritornare a scrivere. Appena un anno prima era stato pubblicato il suo terzo romanzo, un grande successo che lo aveva consacrato scrittore dell’anno. Nei suoi libri aveva rivoltato e scucito la sua vita, l’infanzia, la famiglia, le sue origini ebraiche. La cenere sparsa sui tetti dell’Europa ora gli sembrava un peso troppo grande da sopportare, perciò scrivere, centrifugare realtà e immaginazione gli pareva l’unica fuga possibile.
Un giorno Philip si ricordò di Nathan e del suo viaggio. Nathan gli raccontò di aver percorso la sua transumanza creativa dirigendosi a nord. Il freddo e il gelo, diceva Nathan, svuotano la mente dal caos delle parole molli, quelle che ammuffiscono sui quaderni e che poi si stendono alla luce di fogli virtuali sperando di eliminare la puzza di emozioni e nostalgie. Fu il ricordo di queste parole a convincere Philip che il nord era la sua terra promessa. Allora Philip partì e si nutrì di chilometri e speranza. Fece poche soste, soltanto quelle necessarie per riempire lo stomaco e vuotare la vescica. Voleva arrivare prima, prima di cosa non lo sapeva ancora, ma prima.
La sua corsa verso quel prima fu bruscamente interrotta. L’autostrada era bloccata. Incidente, diceva la radio, brutto scontro fra più automobili, forse morti. Philip non aveva voglia di consumare le ore in sterile attesa e allora prese la prima uscita, quella con la curiosa indicazione stradale “Percorso alternativo. Il viaggio continua”. Un cartello alquanto bizzarro da trovare in autostrada, pensò Philip. Ma forse le cose negli ultimi tempi erano cambiate e il suo isolamento lo aveva escluso dalle nuove forme di comunicazione.
Philip guardò lo specchietto retrovisore e fece bye-bye alla lunga coda di auto e una sottile felicità gli si dipinse sulla faccia.
Era già molto tardi quando incrociò una città, in giro non v’era anima viva. Pensò di andare oltre, alla prossima città, si disse, mi fermo in un motel e domattina riprendo il viaggio.
Improvvisamente alti blocchi di cemento come tagli netti sulla lingua d’asfalto gli impedirono di proseguire. E mentre i fari della sua auto illuminavano il cemento di quei corpi immobili lui non ebbe nessun pensiero se non quello di tornare indietro. Ma il viaggio era la sola speranza che aveva, desiderava la sua transumanza creativa per conquistare le storie che erano al nord ad aspettarlo.
Fece inversione e in una strada secondaria vide lampeggiare un’insegna dalle fluorescenti lettere blu: Bar Voyage. Quando Philip varcò la soglia del bar nessuno si voltò per vedere chi fosse entrato a quell’ora. Si sedette al bancone nell’unico posto libero. Altri uomini erano seduti ai tavoli disposti lungo la parete. Sembrava un luogo per reduci di guerra perché a più di un tavolo erano appoggiate stampelle o strani grovigli di ferro come artificiali e rudimentali arti. Al tavolo in fondo, invece, era seduto uno strano tipo che indossava un mantello nero e un cappuccio che gli copriva interamente la testa. Di lui e della sua faccia, se mai ne avesse avuta una, Philip non riusciva a vedere nulla se non la spessa trama del mantello.
Con lo sguardo Philip tornò a osservare il bancone e le figure immobili come statue di cera che vi erano sedute. Fu allora che notò al suo fianco un uomo senza la mano destra che per bere non usava la sinistra ma calava la testa sul bancone, sfiorava il bicchierino con le labbra, lo afferrava con i denti e con un solo colpo del collo scolava il contenuto del piccolo cilindro di vetro.
Philip fece un cenno al barista e il tipo gli portò un bicchierino ma senza riempirlo. Aspettò qualche minuto poi di nuovo gli fece un cenno con la mano. Questi non si mosse e dal fondo del bancone gli rispose che lui, per ora, non aveva il permesso di bere. Permesso? E da chi?, chiese Philip. Ma il barista gli voltò le spalle e continuò a riempire i bicchieri degli altri avventori. Il barista aveva un viso scavato, la pelle attaccata al cranio come se ogni muscolo, della faccia e del corpo, fosse stato risucchiato.
Al Bar Voyage nessuno fiatava. In un bar le persone vengono per non sentirsi sole, pensava Philip, si stravaccano sulle sedie per parlare delle incongruità della vita, dei quotidiani affanni, di ani da sfondare e fiche da leccare. Almeno era quello che lui aveva sempre immaginato si dicesse in un posto del genere.
Impaziente Philip iniziò a battere il bicchiere vuoto sul tavolo per farsi notare, per provocare qualche reazione. Minaccioso il barista andò verso di lui e gli fece un cenno col capo. Philip lo seguì con il suo bicchiere vuoto. L’ossuto barista gli indicò un tavolo, gli fece di nuovo un cenno con la testa e Philip si sedette.
«Adesso arriva» disse l’uomo.
«Arriva chi?» domandò Philip.
Dal tavolo in fondo alla sala si alzò il tipo con il mantello e si avvicinò a Philip. Si sedette con lui senza dire una parola.
E mentre Philip cercava di capire chi o cosa si nascondesse sotto quel cappuccio, ebbe un brivido lungo la schiena come se la punta di un iceberg lo attraversasse da parte a parte.
«Che ci fai qui?» gli chiese l’uomo con lo spesso mantello.
Ma Philip non riusciva a parlare, era profondamente turbato per ciò che non riusciva a vedere.
«Ripeto, che ci fai qui?» insistette l’uomo.
«Sto aspettando Godot per andare all’altro mondo. Contento?» disse Philip infastidito dall’arroganza di quell’uomo.
«Credi di scherzare? Questo non è un posto dove si arriva per caso. Se sei qui c’è una ragione precisa e tu lo sai. Qui se entri non sempre ne esci. Forse non ti è chiaro in che faccenda ti sei messo».
«Cos’è questa? Una minaccia?» ribatté Philip.
«Dove è successo?».
«Successo, cosa?».
Philip s’innervosì, sbottò qualche bestemmia poi cercò di alzarsi per andare via. Cercò di alzarsi, appunto. Inclinò leggermente il busto verso il tavolo ma non sentiva più le gambe. Allora guardò in basso sulla sedia.
«Le gambe! Dove sono finite le mie gambe?» urlò. Lanciò il bicchiere contro il muro e mille cocci di vetro illuminarono l’aria. Imprecò come mai aveva fatto in vita sua.
Le gambe erano di colpo sparite e ora era lì inchiodato su quella sedia dinanzi a quell’uomo senza faccia che come un buco nero gli frugava dentro.
Silenzio. Adesso il bar, senza la sua voce, era ancora più vuoto e lugubre. Un silenzio impietoso.
«Ti rifaccio la domanda» disse il tipo con il cappuccio «che ci fai qui?».
Philip pensò a un sogno. Ecco forse stava solo sognando, forse si era fermato in un motel lungo la strada, aveva preso una camera e lì, stanco del viaggio, si era addormentato profondamente. Quindi poteva stare tranquillo perché le sue gambe erano state soltanto sacrificate dalla sua onirica irrequietezza. Allora pensò che per uscire da quel macabro sogno doveva solo stare al gioco e raccontare tutta la verità.
«Che tu ci creda o no» disse Philip all’uomo con il cappuccio «ho perso… ho perso le parole. Fino a un anno fa scrivevo, ho pubblicato tre romanzi e fatto un bel po’ di grana. Poi non so cosa sia successo ma da un giorno all’altro le lettere non si sono più messe in fila a formare parola, le parole non hanno più composto i paragrafi e i paragrafi non hanno riempito i fogli per diventare storie, le mie storie. Sono di colpo spariti gli ingorghi e gli incroci delle narrazioni. Ho dentro un deserto come quello delle città dopo le inondazioni o i terremoti. Tutto svanito. Andato, perso chissà dove. Ero in viaggio per il nord. Lì le parole le trovi in ogni angolo perché il freddo le cristallizza e come i fiocchi di neve diventano ghiaccio compatto. Incidenti e lavori in corso mi hanno sbarrato ogni accesso e vietato di proseguire. Mi sono trovato nel cuore della notte in questa città fantasma e l’unico segno di vita era l’insegna fluorescente di questo posto».
Intorno a lui ancora silenzio.
Philip piegava la testa ora a sinistra ora a destra per cercare disperatamente lo sguardo di chi gli stava di fronte. Provava terrore e l’unica cosa che ora desiderava era scappare, fuggire via da quell’infinito vuoto dentro cui sentiva sprofondare tutta la sua speranza.
Allora il tipo col cappuccio fece roteare la mano nell’aria e dopo qualche istante arrivò il barista con un nuovo bicchierino e una bottiglia di gin. E mentre gli versava da bere gli sussurrò: «Bevi, stanotte ne avrai bisogno».
«Allora vuoi sapere dove sei? E soprattutto perché hai perso le gambe?» gli disse la voce dal buco nero.
«No, non lo voglio sapere» rispose Philip.
Chiuse gli occhi allargò le braccia portò il capo all’indietro e si lasciò cadere. Un volo interminabile come se il tempo non avesse più posto tra lui e il mondo. Sentì il tonfo del suo corpo e il freddo del pavimento sulla sua guancia. Poi nulla, nulla più.
Quando riaprì gli occhi, Philip vide i fogli accatastati ai piedi della sua scrivania e dei cocci di vetro sparsi sul pavimento. Si alzò lentamente, guardò le mani che erano un labirinto di piccole ferite e sangue rappreso.
Le fissò come se quelle non fossero le sue mani, le sue dita, il suo corpo.
Allora capì che per tornare a scrivere non serviva un viaggio, perché pur partendo avrebbe lasciato se stesso tra la scrivania e i fogli scarabocchiati. Quello che doveva fare era mutilare la sua presenza perché ogni storia inventata richiede un sacrificio e per ogni parola posata sul foglio un pezzo della sua esistenza doveva svanire per ricomporsi, pezzo dopo pezzo, nei suoi racconti. Quello che lasci di vero o verosimile nelle storie nessuno lo sa, pensava Philip, e quello che invece ci trovi è solo una faccenda tra chi narra e chi è narrato. O come diceva Nathan: annullarsi fino a dimenticare il nome di chi ti ha partorito e inabissarsi nella propria assenza come una funambolica fuga dalla realtà.
©MimmaRapicano_giugno2016